Se c’è una cosa che ho imparato dell’attivismo, con considerevole ritardo aggiungerei, è che non si arrivi mai da nessuna parte. Mi spiego meglio: non arriverà mai il giorno in cui avrai ascoltato abbastanza persone, letto abbastanza libri e fatto abbastanza esperienza. Ho imparato a mie spese che, se voglio mantenere il mio attivismo utile, inclusivo e intersezionale, la parola “abbastanza” deve sparire dal vocabolario.
Intersezionale: davvero basta dirlo?
Essere intersezionali significa non dimenticarsi delle altre esperienze, diverse dalla propria e lontane dal proprio campo. In una società dove le discriminazioni sono sistemiche, nessuno è senza peccato. Il mio primo approccio vero con l’antirazzismo, per fare un esempio, è stato smetterla di dire “io non sono razzista”, smettere in qualunque contesto di sottolineare la mia apertura. Per quale motivo? Perché se sei bianc* e dici di non essere razzista, molto probabilmente stai mentendo e non ne sei consapevole.
Perché non puoi dire di non prendere parte a quel sistema, se non conosci quel sistema, ignorandone la localizzazione e le caratteristiche. Questa cosa l’ho provata in prima persona quando si tocca la spinosa questione delle persone “alleate” della comunità LGBTQ+ che attuano comportamenti omotransbifobici e non accettano di metterli in discussione. Il fatto interessante, però, è che dagli errori degli altri nei miei confronti ho aperto gli occhi sui miei.
In che modo posso negare di essere misogino, se la misoginia non la subisco io? In che modo posso dire di essere antirazzista, quando il razzismo non lo subisco io? Una mezza risposta che mi sono dato è stata: smettere di sottolineare queste mie posizioni.
White Saviour Complex
Dal dire “non sono razzista” a “non posso essere razzista” non ci vuole molto. Dire di non poter prendere parte a quel sistema perché ormai lo si conosce, ci si è svegliat* sul tema e che una volta che si entra in contatto con certe tematiche si guadagni una sorta di “immunità”, è stupido e pericoloso.
Questo fenomeno l’ho scoperto quest’anno, è definito White Saviour Complex – nel caso del razzismo. Non è una discriminazione intenzionale, ma nasce da fortissimi bias causati dal privilegio. Quando si parla di White Saviours, l’immagine che associamo a questo termine è quello di una persona bianca che si approccia alle minoranze etniche con fare materno e quindi con un’inconsapevole senso di superiorità che la fa percepire come una “salvatrice” o “protettrice”. La classica immagine della celebrità bianca che si fa le foto con bambini neri, per intenderci.

Stando alle fonti, è chiaro che dietro questo tipo di atteggiamenti c’è una finalità egoistica, volta a performare e non a fare, quindi ad apparire come persone sensibili, belle più che aiutare effettivamente per una causa.
Performative Allyship
Nel caso della comunità LGBTQ+ non siamo a corto di esempi simili. Come ho già detto prima, la performative allyship è un grosso problema nella causa queer.
Molto spesso si generano polemiche di questo tipo intorno al controverso mondo delle fujoshi (termine giapponese che indica le lettrici di Yaoi, solitamente donne eterosessuali che si approcciano in un modo feticizzante a storie di relazioni omosessuali) e alla diatriba sull’inclusione degli Allies nella sigla LGBTQIA+.
Partiamo dal presupposto che la A finale della sigla indica la comunità Aro/Ace, che volerla far stare per indicare invece le persone alleate è irrispettoso nei confronti di quella comunità. Questo è un chiaro esempio di attivismo tossico e performativo: volersi mostrare sensibili a una minoranza coprendo la sua voce e sostituendosi ad essa. Chi fa questo tipo di attivismo e vuole combattere un’oppressione cancellando la voce delle persone oppresse, si sta paradossalmente unendo alla cerchia degli oppressori.
Un altro esempio, uno dei peggiori a mio parere, è quello di sfruttare la sensibilità su questi temi per marketing. Arriviamo subito al sodo: queerbaiting. La nuova serie TV tanto amata che addirittura mette un personaggio secondario queer, un personaggio sviluppato malissimo e dalla dubbia utilità: proprio un passo avanti per la causa. Ma facciamo un altro step avanti nella melma: avete presente quando c’è quel personaggio la cui sessuaità o identità di genere non sia chiara, ma la promozione della serie suggerisce che “potrebbe essere queer” e quando la serie esce, questa tematica non viene minimamente trattata? Ci troviamo davanti a una palese pratica di queerbaiting.
Intersezionale: una riflessione razionale
Negare a priori un proprio comportamento chiude la mente a qualunque tipo di riflessione su di esso, impedendoci di identificare e correggere eventuali sbagli. Fare attivismo significa proprio questo: mettersi costantemente in discussione, scegliere uno stile di vita di costante formazione ed educazione dove non si raggiunge alcun attestato finale. Uscire dall’ottica di dover percorrere una strada in vista di un traguardo finale, in questo caso, sarebbe molto d’aiuto.
L’intersezionalità non vuol dire quindi fare “tutto”, combattere tutte le battaglie possibili attraverso un unico movimento, bensì vuol dire che il movimento deve essere plurale, devono esserci più persone diverse dalle esperienze diverse, che singolarmente danno il loro contributo per il progresso. Condizione necessaria per questa pluralità è, quindi, l’ascolto finalizzato alla comprensione e non ad un tornaconto di qualunque tipo.

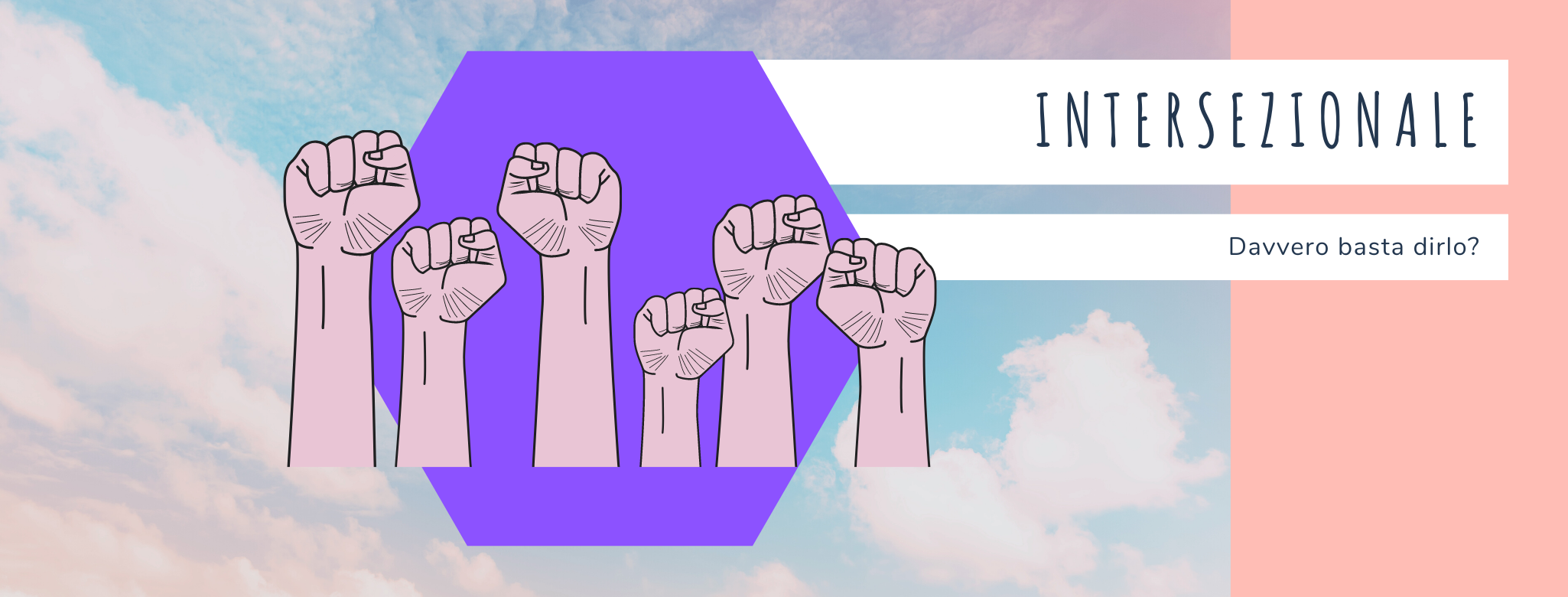
Lascia un commento